Pamuk. La verginità degli oggetti
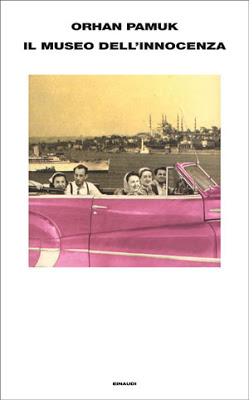
Chiara Scarlato legge Il Museo dell’innocenza, primo romanzo dell’autore turco dopo il Nobel ricevuto nel 2006. Il libro è uscito nel 2009 per Einaudi.
La storia d’amore raccontata da Orhan Pamuk nel romanzo Il Museo dell’innocenza –
come ogni storia d’amore – gode di un certo grado di banalità e
prevedibilità, se si tiene in considerazione soltanto il fatto che in
essa ci sono un inizio, uno sviluppo e una fine, così come accade in
generale per qualsiasi tipo di narrazione. Tuttavia, questo particolare
tipo di esperienza mimetica testimonia uno dei modi grazie ai quali il
soggetto aumenta la capacità della sua memoria, utilizzando gli oggetti
come depositi di ricordi.
Infatti Kemal e Füsun – i due personaggi principali – raccontano se
stessi soltanto attraverso i ricordi e le parole che i loro oggetti
hanno registrato e, in un certo senso, tradotto in qualcosa di
immateriale. Lo stare al mondo di Kemal, in seguito all’incontro
fortuito con Füsun, si modifica in maniera sostanziale al punto che
l’uomo inizia a raccogliere tutti gli oggetti che sono entrati in
contatto con le parti del corpo di Füsun, tutte quelle cose che hanno
registrato presenza tattile e che ora sono le uniche in grado di portare
il senso dell’assenza in tutta la sua tragica presenza. Füsun, infatti,
ha reiterato la propria morte dentro agli occhi di Kemal ogni volta che
il suo corpo non è stato davanti a quegli stessi occhi: l’obiettivo di
Kemal di continuare a vivere in presenza di Füsun si completa nel
riconoscimento di una certa permeabilità della materia che permette di
considerare gli oggetti come estensione di un corpo. Questo accade
perché gli «oggetti che sopravvivono a quei momenti felici conservano i
ricordi, i colori, l’odore e l’impressione di quegli attimi con maggiore
fedeltà di quanto facciano le persone che ci procurano quella felicità»
(p. 79).

Ma non si tratta soltanto di questo. Partendo dal presupposto che
ciascuno ha la tendenza a potenziare la propria singolarità nel rapporto
con l’altro, Kemal nel suo Museo dell’innocenza non vuole soltanto
vivere i ricordi di lei ma anche reiterare i differenti stati che hanno
segnato il passaggio verso il punto in cui le loro vite si sono
incontrate. Nell’edificio che un tempo era stato l’abitazione di Füsun,
Kemal accumula e riposiziona degli oggetti che diventano chiavi di
accesso per la sistematizzazione puntuale di una serie di suggestioni –
solitamente disordinate e presenti nei ricordi – che disegnano e
trasformano esperienze vissute in qualcosa di non già realmente
accaduto, poiché non più autentico ma frutto di una seconda elaborazione
e di una successiva traduzione, in un processo di infinita e reiterata
significazione.
In questo procedimento, l’oggetto rappresenta il punto fondamentale
di accesso alla memoria, considerando la sua costituzione sostanziale di
elemento parlante. Esiste infatti una differenza terminologica tra
oggetto (Gegenstand) e cosa (Ding) e, nella
prospettiva heideggeriana, un oggetto può diventare cosa soltanto quando
riesce a trasmettere l’immagine di un mondo nel «gioco di specchi della
semplicità di terra e cielo, divini e mortali». La quadruplicità di
terra, cielo, divini e mortali costituisce il Geviert, cioè il
dispositivo che permette di comprendere la doppia natura della cosa nel
suo movimento di presenza e assenza.
È soltanto attraverso la cosa che è
possibile ascoltare l’imperfezione dell’essere umano che si racconta
tramite le cose, seguendo un linguaggio che non può essere
interiorizzato, né può acquisire un significato nel sistema di normale
codificazione simbolica.
Questa incompletezza – del tutto evidente nella vita di Kemal e Füsun
– è raccontata da una quadruplice operazione che riesce a rendere
l’amore che li ha legati una categoria attraverso la quale esperire una
nuova modalità di passaggio nella considerazione di ciò che da oggetto
diventa cosa. Il gesto di Kemal di raccogliere gli oggetti della vita
segmentata che si legge nelle tazzine ancora macchiate dalle tracce di
tè, nei soprammobili, negli abiti, nella grattugia e in tutto ciò che
effettivamente è stato parte dei giorni suoi e dei giorni di Füsun – e
che potenzialmente potrebbe essere parte della vita di una qualsiasi
persona altra, mantenendo un investimento di significato del tutto
differente – si completa nel racconto di Kemal allo scrittore Orhan
Pamuk che decide di fissare in un romanzo la narrazione di queste vite e
dei loro oggetti, non ancora cose. Una prima appropriazione del
processo di trasformazione si sviluppa quando il lettore trova analogie
tra gli oggetti rappresentati e le cose a cui si lega la sua particolare
vita, ma l’esperienza si potenzia ulteriormente quando la casa riempita
da Kemal con tutti gli oggetti che lui ha raccolto nella sua collezione
subisce una trasformazione e da luogo privato diventa un luogo
pubblico: il Museo dell’innocenza.
Nel rapporto di fruizione che l’individuo instaura con gli oggetti
che lo circondano, esiste uno scarto di incommensurabilità che rende
quegli stessi oggetti dei punti di apertura e di riappropriazione
comune, soprattutto quando questi risultano dislocati dal loro ambiente
naturale in una dimensione di ricostruzione e riposizionamento: nello
spazio del museo di Istanbul la storia di due singolarità si potenzia in
storia comunitaria.

Il museo in se stesso è un luogo dell’incompletezza
perché la sola visita non restituisce alcuna narrazione: è come se si
entrasse all’interno di un negozio di antiquariato con dei proprietari
eclettici che hanno deciso di disporre la merce in una maniera insolita.
Per riuscire a trovare quella complementarità che Kemal ha vissuto
con Füsun non è sufficiente entrare nei loro luoghi e nei loro oggetti
ma occorre ascoltare il racconto di Kemal, ascoltarlo nel linguaggio
letterario mediato dalla figura dello scrittore Orhan Pamuk che
realmente aveva incrociato la vita di queste due persone, risignificate
in personaggi. Pamuk diventa Kemal nel romanzo e traduce ancora una
volta la storia in modo tale che possa diventare materia di finzione,
portando in primo piano il ruolo che gioca la distanza tra lettore e
scrittore nell’appropriazione di un testo letterario, dal quale non ci
si aspetta alcun contenuto di realtà.
Eppure, come era accaduto già nell’incipit del lungo saggio dedicato alla sua Istanbul,
Pamuk enfatizza il rapporto che la sua scrittura intrattiene con il
lettore, privilegiando un discorso che lega la fiducia all’ascolto,
consapevole del fatto che l’unica seconda esistenza che si può vivere è
racchiusa all’interno del «libro che si ha tra le mani» (p. 9) e che per
questo il lettore deve affidarsi allo scrittore così come un amante
deve affidarsi alla persona che ama e viceversa. Soltanto sulla base di
questo presupposto è possibile instaurare un rapporto di corrispondenza
grazie al quale la memoria diventa il dispositivo di conservazione della
vita stessa.
La storia degli oggetti del museo nasconde il suo carattere
intertestuale nell’attivazione di un processo cognitivo autonomo che è
parte della percezione di ciascuno dei visitatori e il documentario Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk,
girato da Grant Gee, mette in luce le diverse implicazioni che si
sviluppano contestualmente a questa operazione. Le immagini delle stanze
della casa rappresentano il simulacro esterno di una Istanbul che non
trova più i suoi racconti negli oggetti conservati. La città è dislocata
in una temporalità presente che non vive più di quei significati e che
tuttavia di volta in volta riesce ad accendersi e spegnersi nei ricordi
delle testimonianze dirette di chi ha regalato un po’ di memoria a
quegli oggetti, una memoria che per sua costituzione non può più trovare
alcuna verifica esperienziale. In questo modo, la raccolta maniacale
degli oggetti sporcati da unici segmenti di vita diventa strumento
essenziale per la costruzione di contenuti che riescono a svilupparsi
soltanto all’interno di una narrazione, che, in questo caso, coinvolge
inoltre diversi piani di sovrapposizione.

Infatti, nel documentario si
incrociano due linee biografiche: la vita di Kemal, racchiusa
nell’edificio e la vita di Orhan, racchiusa nelle strade di Istanbul.
Kemal trova le parole per raccontarsi nella voce fuori campo che legge
alcune parti del romanzo, accompagnate dalle riprese degli oggetti che
completano la narrazione mentre Orhan si racconta durante un’intervista
con il giornalista Emre Ayvaz e le immagini di questo scambio si
incontrano su schermi di vecchi televisori, in locali e stanze
abbandonate. E poi c’è Istanbul, Istanbul con le sue macchine e la sua
gente, Istanbul che vive di notte. Sono due prospettive a confronto: la
fissità degli oggetti contro il movimento del cambiamento che non riesce
a trovare una forma in qualcosa di stabile e per questo spinge a
ritrovare un’identità perduta nel passato e a lasciarla lì, conservata, a
comporla nello spazio definito per riuscire ad abbandonarla, in
definitiva.
A questo punto, non diventa nemmeno più importante conoscere se Kemal
e Füsun siano realmente esistiti e se quegli oggetti abbiano davvero
toccato le loro vite. Il gesto fondamentale è al contrario riuscire a
entrare in contatto con le cose, lasciare che la nostra memoria le
tocchi e poi aggrapparsi a esse per liberare e togliere il peso delle
immagini che raccolgono le emozioni e le persone, che registrano gli
ambienti e le situazioni.
Il Museo dell’innocenza è proiezione di
condivisione della possibilità di continuare a vivere nel continuo
movimento di dono e restituzione in cui si confrontano i diversi momenti
dell’esistenza di ciascun individuo che da solo non può comporre la
propria esistenza. Lasciare spazio e parola alle cose, scrivere su di
esse e dentro esse, impossessarsi della loro vita e portarle fuori dal
loro stato di verginità: utilizzarle come strumenti di estensione per
continuare a riempire di significato le giornate, senza perdere nulla di
ciò che è stato.


